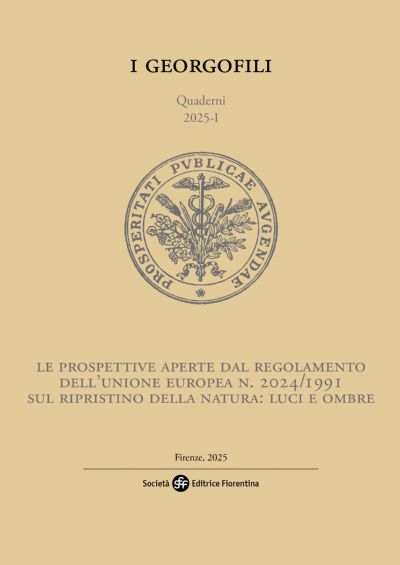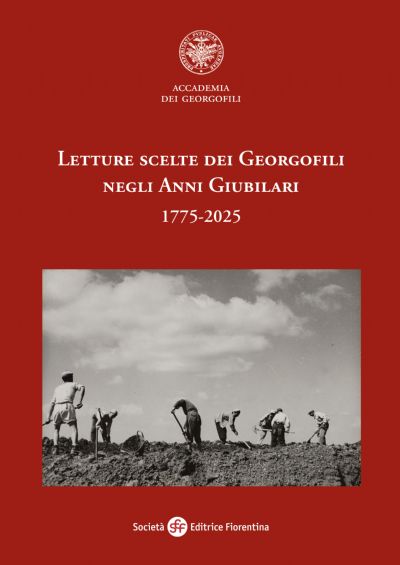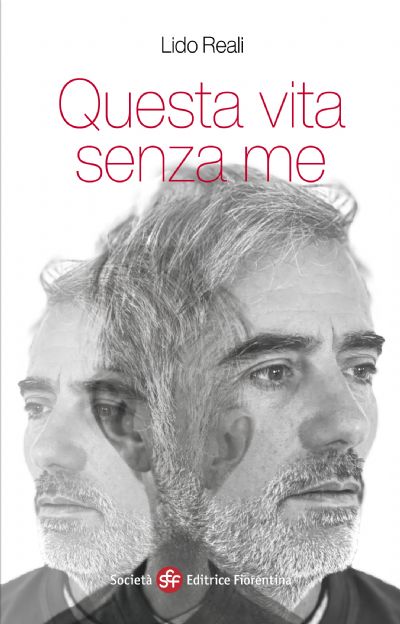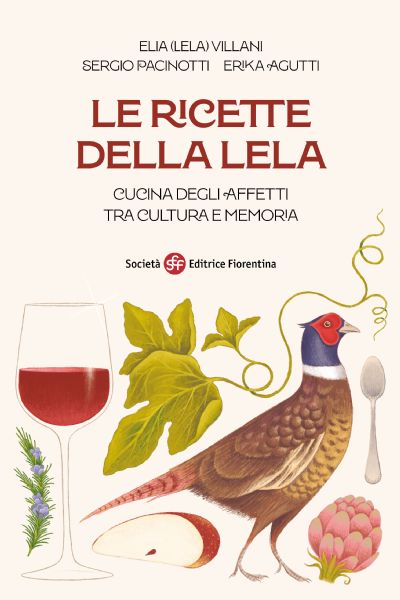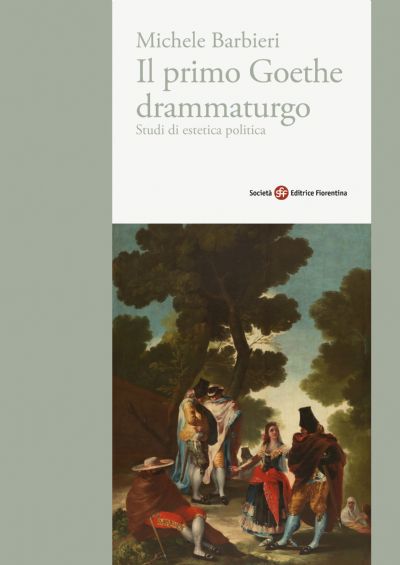
Michele Barbieri
Il primo Goethe drammaturgo
Studi di estetica politica
Dopo la prima edizione, uscita nel 1995 in concomitanza con la guerra di smembramento della Federazione Jugoslava patrocinata da una Germania appena riunificata, questa seconda edizione ribadisce l’interesse per i caratteri della drammaturgia delle nazioni mediante uno scambio di sguardi tra filologia delle forme e critica del giudizio. La trattazione principale esamina le prime opere drammaturgiche del giovane Goethe procedendo a ritroso sull’antropologia dei personaggi: dal Götz von Berlichingen ai Complici all’Umore dell’amante – per poi dare dell’insieme della tradizione idillica una rappresentazione impressionistica. Studi più recenti, pubblicati nelle Appendici, trattano del rapporto tra politica e letteratura, nonché delle possibilità teoriche di un’estetica politica.
A lato d’una estetica ‘della’ politica (come la Roma imperiale e la Terza Roma, la Festung Europa, la Grandeur, la Madre Russia, il Make America Great Again...), un’estetica politica può esercitarsi sui corpi di arti e letterature per vie d’accesso morfologiche e filologiche. L’impegno non è nuovo: alla sociologia della seconda Democrazia in America di Tocqueville, Burckhardt e Warburg preferirono la storia della cultura, fino a Francis Haskel. Più recenti sono accessi di carattere tecnologico e statistico su temi geopolitici. Gli accessi letterari di Giovanni Necco, dai quali questo studio trasse ispirazione, si sono rinnovati con opere come quelle di Richard N. Lebow, di Nicolai Petro e con il libro di Paul Geyer Da Dante a Tasso sull’adolescenza europea, rompendo gli indugi a questa nuova edizione, che insiste sull’idea del soggetto antropologico come essere complesso unito, come una federazione, grazie al doppio significato del termine “costituzione”.
Trent’anni dopo, il riferimento agli eventi della politica mondiale s’è ripetuto; e un secolo dopo il fallimento del Piano Schlieffen è del pari fallito il piano occidentale di rapido saccheggio e smembramento della Federazione Russa. Sotto il profilo filosofico-politico l’autore interpreta entrambi gli eventi come tipici fallimenti del criticismo: il quale nel pensiero teorico ha prodotto i professori di filosofia, e nel pensiero politico ha spento il ruolo della cultura e dell’immaginazione. Esso rimane il pericolo principale per l’azione politica, dal momento che negli ottimismi dello storicismo non crede più nessuno – ma mentre una Miseria dello storicismo è stata scritta, soltanto i fatti oggi parlano della miseria del criticismo: dell’ostinarsi a dare certezza all’induzione che, con l’inevitabile aleatorietà del risultato, non lascia esiti pratici diversi fra pervicacia categorica e attivismo provocatorio. A differenza delle discipline dell’intelletto, procedenti da assunti, le discipline della sensibilità insegnano che i presupposti del giudizio e dell’azione sono miriadi di ombre delle idee.